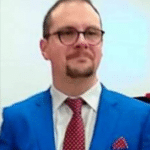Scarica QUI la Rivista n.0 di Policlic!
Marco Follini è un importante protagonista della vita politica italiana del periodo repubblicano. Ha infatti ricoperto rilevanti ruoli sin dall’inizio della sua esperienza politica, avvenuto nelle fila della Democrazia Cristiana, del cui movimento giovanile è stato Segretario nazionale dal 1977 al 1980. In seguito, diviene uno dei componenti della direzione nazionale del partito, facendone parte per sei anni, dal 1980 al 1986. Dal 1987 al 1993 fa parte del Consiglio di amministrazione della Rai.
Negli anni della cosiddetta Seconda Repubblica, Follini ha modo di arricchire il suo già ragguardevole cursus honorum: nel periodo che va dal 1996 al 2013, infatti, è prima deputato e poi senatore, con un’esperienza da Vice-Presidente del Consiglio nel secondo
governo Berlusconi. Nello stesso periodo, affianca all’attività parlamentare e di governo, quella di partito. Dopo lo scioglimento della DC, infatti, Follini prosegue la sua militanza politica prima nel Centro Cristiano Democratico e poi nell’UDC, ricoprendo
in entrambi i partiti la carica di Segretario nazionale. Successivamente è tra i fondatori del Partito Democratico, che abbandona nel 2013.
La passione per la politica si sostanzia anche nella proficua attività di giornalista e scrittore, a cui Follini si sta dedicando con intensità sempre maggiore. È di recente pubblicazione il suo ultimo lavoro (Democrazia Cristiana: il racconto di un partito, Sellerio 2019), un’analisi delle principali caratteristiche e attitudini del partito che per un cinquantennio ha governato
la Repubblica Italiana, e che costituisce l’oggetto di questa intervista che Follini ci ha concesso.
Con riferimento all’esperienza democristiana, come spiega il fatto che l’unità politica di tutti i cattolici fosse perseguita e custodita con estrema cura? Ritiene che in nome di essa si sia sacrificato qualcos’altro?
A suo tempo la DC si definiva come un partito di cattolici e non come il partito dei cattolici, con questo si voleva dire che ovviamente la gran parte del mondo cattolico era dentro il perimetro democristiano, ma non tutta. Ce n’era una parte che, condividendo la stessa sede, ne traeva conseguenze politiche diverse. In questo tratto di laicità, di autonomia della sfera politica, io penso che ci fosse il meglio della tradizione del cattolicesimo democratico. Questa era la differenza tra una forza che aveva una caratteristica di apertura e una forza integralistica quale la DC non è mai voluta essere.
Nella rassegna che lei fa di alcune tra le principali personalità democristiane, emergono, tra gli altri, due personaggi molto diversi tra loro, per certi versi forse agli antipodi: Aldo Moro e Giulio Andreotti. Com’era il rapporto tra i due, a livello personale e politico?
Moro e Andreotti avevano imparato a convivere sin dai tempi della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana, NdR), che ha rappresentato la loro prima esperienza, e poi in lunghi anni di militanza di partito e di governo, se così si può dire. Erano persone che sapevano tener conto l’uno dell’altro, pur non amandosi particolarmente. Moro considerava Andreotti – come trapela drammaticamente dalle lettere dal carcere – un uomo politico di un certo cinismo. E Andreotti considerava Moro un maestro dell’astrazione.
Poi la convivenza ha reso questo conflitto meno dirompente, ma non c’è dubbio che in fondo all’animo dell’uno e dell’altro ci fosse un sentimento conflittuale, per così dire. La forza di quei partiti e di quella classe dirigente era di non farsi trascinare dalla disputa personale, ma di trovare poi dentro le mura della propria formazione politica un’occasione per convivere, qualche volta armoniosamente, qualche volta forse un po’ meno.
Lei descrive il rapporto tra DC e PCI come un “insieme di avversione e sottaciuta complicità” e come una “quasi benevola inimicizia”. Un simile stato di cose fu la conseguenza di un disegno deliberatamente portato avanti dai due partiti, o invece fu un approdo non preventivato della fisiologica dialettica politico-partitica? Come si traduceva questo rapporto tra i due partiti sul piano politico e pratico?
Diciamo che i partiti di quella stagione erano anche delle fondamentali cattedre educative. I dirigenti democristiani e quelli comunisti – ma lo stesso discorso si potrebbe fare anche per gli altri – cercavano di guidare la loro base, e di condurla a un esito più comprensivo delle ragioni di coesistenza con altri filoni, altre culture e altri progetti. Se si fosse chiesto negli
anni ‘50 al democristiano medio: “cosa fare dei comunisti?”, molti avrebbero detto: “mettiamoli fuori legge”. E se fosse stato chiesto ai comunisti che cosa fare dei democristiani, molti di quelli che militavano a sinistra avrebbero detto “prendiamo le armi che abbiamo lasciato nei cascinali all’indomani della guerra”. C’era, diciamo, un’esasperazione reciproca, che il contrasto ideologico rendeva lacerante e dirompente,
e l’avvedutezza di quei gruppi dirigenti fu appunto di ricondurre tutte queste passioni dentro un alveo di convivenza. In questo occorre rendere onore al merito ai leader di partito, che anziché seguire la pancia della loro base elettorale, sapevano guidarla verso un
esito più costruttivo.
Nel libro si fa menzione di un Ufficio per i rapporti con il mondo cattolico interno al partito. Quali erano le sue funzioni? Godeva di un certo margine di manovra all’interno del partito, o invece era strettamente inquadrato all’interno delle sue strutture?
Era un ufficio dedicato ai rapporti con l’associazionismo cattolico, perché in tutti gli anni ‘60 e ‘70 assistiamo a una fioritura di associazioni che prendono anche le direzioni politiche più diverse, e che avevano bisogno di trovare nella DC una possibilità di interlocuzione. Come ho raccontato nel libro, per molti anni questo compito fu affidato alla saggezza diplomatica
di una deputata di Lucca, Maria Eletta Martini, che lo gestì sempre con grande discrezione e in modo molto appropriato. Era curioso che un partito che veniva da quel mondo sentisse poi il bisogno di strutturarsi attraverso un ufficio che si occupasse delle relazioni con le più diverse diramazioni di quello stesso mondo, che però era fondamentalmente il mondo democristiano.
La sua lunga militanza democristiana si può chiaramente dedurre dal linguaggio adottato e dalle tecniche di scrittura utilizzate nella stesura del libro. Ha avuto modo di frequentare la scuola di formazione della Democrazia Cristiana? Come era strutturata?
Io ho avuto la fortunata circostanza di esordire con un ruolo già di dirigente, perché ho cominciato nel movimento giovanile, e il primo passaggio importante fu per me il congresso di Bergamo in cui venni eletto segretario. Quindi, maliziosamente si può dire che mi sia iscritto anche io da giovane alla direzione, e quindi non si è passati per i gradi intermedi che formano un buon dirigente politico. C‘erano corsi di formazione? Devo dire che erano meno strutturati, meno impegnativi di quelli che si svolgevano presso i nostri dirimpettai dei PCI alle Frattocchie. C‘era una minore attenzione al processo di formazione; per certi aspetti mi viene da dire che lo abbiamo svolto sul campo, nell‘azione politica. Tuttavia, avevamo da giovani la consapevolezza che di fronte a noi stava una classe dirigente fatta di persone importanti, che reggevano il peso dello Stato, che riservavano a noi giovani molta attenzione, ci ascoltavano, ci tenevano da conto, elargivano qualche confidenza, di quelle non dovute, e però nello stesso tempo si aspettavano da noi un processo di maturazione. In qualche modo ci facevano sentire non proprio sui banchi di scuola, ma comunque come persone che avevano molto da imparare. E questo tratto che ha contrassegnato il
passaggio delle generazioni nella vita democristiana, io credo che sia stato molto educativo, per tanti.
Al netto della collocazione atlantica, nel campo delle democrazie liberali, che pur con diverse sfumature caratterizzava la politica estera della Democrazia Cristiana, erano presenti all’interno del partito correnti o personalità che intrattenevano rapporti privilegiati con singoli Stati?
No, non si può dire che ci fossero politiche estere, come dire, personali. C‘era un’attenzione complessiva che teneva insieme la scelta europea, l’alleanza atlantica e una certa libertà di movimento, soprattutto nello scacchiere mediterraneo. La politica verso il Medio Oriente di tutti i grandi leader democristiani, da Moro a Fanfani ad Andreotti, per citare soltanto quelli più in vista, fu una politica che si concesse qualche libertà rispetto alla ortodossia atlantica più rigorosa degli anni della Guerra fredda. Così come ci fu un’attenzione al mondo sovietico, che era probabilmente un po’ più larga di quanto i cultori della realpolitik avrebbero apprezzato. Fermo restando un quadro di alleanze che è sempre rigorosamente rimasto quello europeo e quello atlantico. La DC chiude l’epoca dei “giri di valzer”, chiude il periodo ballerino della nostra politica estera, e riconsegna l’Italia a uno schema, che è quello appunto occidentale, atlantico, europeo. Poi l’interpretazione di questo schema si concesse qualche libertà in più.
A proposito delle vicende di Tangentopoli, lei sostiene che la crisi morale divenne negli anni ‘90 una crisi politica, per ragioni più politiche che morali. Cosa intende? Quali sono a suo parere le ragioni politiche che hanno contribuito a dar luogo a quelle vicende?
Quando arrivò la “onda di piena” di Tangentopoli, in molti pensavano che fosse lo scorrere dei titoli di coda della Prima Repubblica, come in parte probabilmente è stato, e da questo, nel furore e nella confusione di quei mesi, di quegli anni, si sono tratte molte e diverse conseguenze. Diciamo che la lettura che la gran parte dei media, dell’intellettualità italiana, ha dato di Mani Pulite, si è rivelata col tempo una lettura molto generosa. La gran parte delle persone che sono salite sul banco degli imputati si è rivelata innocente. Alcuni di quelli considerati, in termini strettamente legali, come colpevoli, erano in molti casi – penso a Citaristi, per esempio – persone perbene che svolgevano una funzione politica, e l’idea che per la magistratura fosse l’occasione per una purificazione etica della politica italiana conteneva in sé un errore. Quell’errore non è stato contrastato. Se si potesse riavvolgere la pellicola e ripartire da capo, direi che avremmo dovuto essere molto più rigorosi contro la corruzione negli anni precedenti, ma anche rigorosi nel difendere noi stessi dall’idea che
la magistratura stesse riscrivendo la storia d’Italia, come in parte si è lasciato correre, e con il risultato che abbiamo visto molti galantuomini alla sbarra e molti magistrati che hanno fatto un uso largamente disinvolto delle loro prerogative. Alcuni di loro, penso a Di Pietro, buttandosi in politica cercando di trarne un profitto, che non mi è mai sembrato di particolare nobiltà.
Prima che si giungesse allo scioglimento della DC, e sulla scia di una sempre più marcata tendenza al bipolarismo, cosa ha impedito al partito di collocarsi nell’area di centro-destra, sul modello della CDU tedesca?
È stato di impedimento il fatto che il centrodestra avesse assunto caratteristiche che erano piuttosto dirompenti rispetto alla tradizione democristiana. Perché c‘era un leader, Berlusconi, con una personalità sin troppo forte, per così dire, una leadership fin troppo debordante. C‘era un‘apertura a destra laddove i democristiani, anche quelli più moderati,
avevano messo un paletto oltre il quale non si poteva andare. Per cui, col senno di poi, e forse anche in parte col senno di allora, viene da dire che fu un errore non mantenere il rapporto con il nostro elettorato, gran parte del quale si è poi andato ricollocando nel centrodestra. Però capisco anche che quello che avvenne colse un po’ tutti in contropiede; nessuno si aspettava che il bipolarismo, che nella immaginazione di molti di noi avrebbe dovuto essere tra democristiani e comunisti, potesse svolgersi in modo tale che i democristiani fossero un po’ di qua e un po’ di là, e nessuno decisivo né di qua né di là.
Il progetto politico dell’Ulivo e poi quello del Partito Democratico, improntati al pluralismo e caratterizzati dall’intento di creare un contenitore in cui potessero convivere anime, valori e culture politiche differenti, possono secondo lei essere considerati come il tentativo di riproporre in un contesto nuovo la logica democristiana del “partito-paese” o “partito pigliatutto”?
Occorre considerare che quest‘impresa non è riuscita né a Berlusconi nel centrodestra, né all‘Ulivo e poi al PD nel centrosinistra. Perché in realtà troppa parte del patrimonio democristiano, che era fatto anche di prudenza, di misura, di un certo stile, di una visione
complessiva del Paese è andato perduto nel passaggio dalla cosiddetta Prima alla Seconda Repubblica. Dalla parte di Berlusconi c’è stato quello che tutti abbiamo potuto vedere e che per molti versi non è in sintonia con il retaggio democristiano, dalla parte del Partito Democratico c’è stata mescolanza di culture che potevano convivere con una certa fatica dentro un’alleanza, ma che per svolgersi avevano bisogno di un campo più largo. Ridurle dentro il recinto di uno stesso partito, in cui tutti i riformisti – quelli cattolici, quelli socialisti, quelli repubblicani, quelli comunisti, quelli ambientalisti – si mescolassero, si è rivelata una trovata di non grandissimo successo, né per gli uni né per gli altri.
Quali sono stati i suoi principali punti di riferimento all’interno della DC? Chi le ha trasmesso gli insegnamenti più preziosi?
Ovviamente per me è stato cruciale il rapporto con Moro, anche perché avevo con lui un’amicizia molto discreta, riservata, intrisa di un certo pudore, come era nella caratteristica sua e, vorrei dire, anche mia. Per cui non c’era una grande confidenza, ma c’era un rapporto profondo e negli anni mi sono reso conto di tante cose che facevo più fatica a valutare nel mentre le stavo attraversando. Il valore di quel mondo però non stava nella prima fila, il valore dell’esperienza democristiana secondo me si ravvisa meglio ponendo l’occhio alle seconde, alle terze, alle quarte file. C’erano deputati che nessun libro di storia ricorderà, dirigenti periferici, segretari provinciali, figure apparentemente di secondo e terzo piano, che però avevano una visione del Paese, una cultura personale,una capacità di affrontare i problemi che oggi è rara. E la gran parte di questi signori che sono consegnati all’anonimato, hanno in realtà un valore politico molto più profondo di moltissimi dei leader che oggi occupano un po’ abusivamente la prima fila della Repubblica.
Riccardo Perrone per Policlic.it